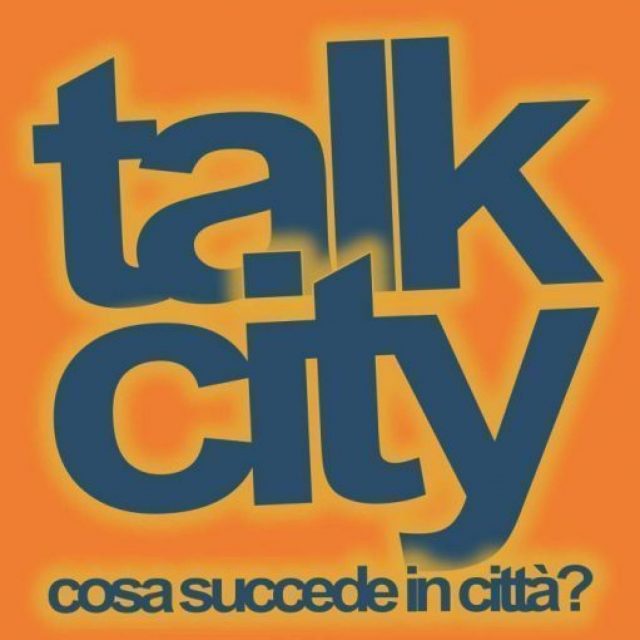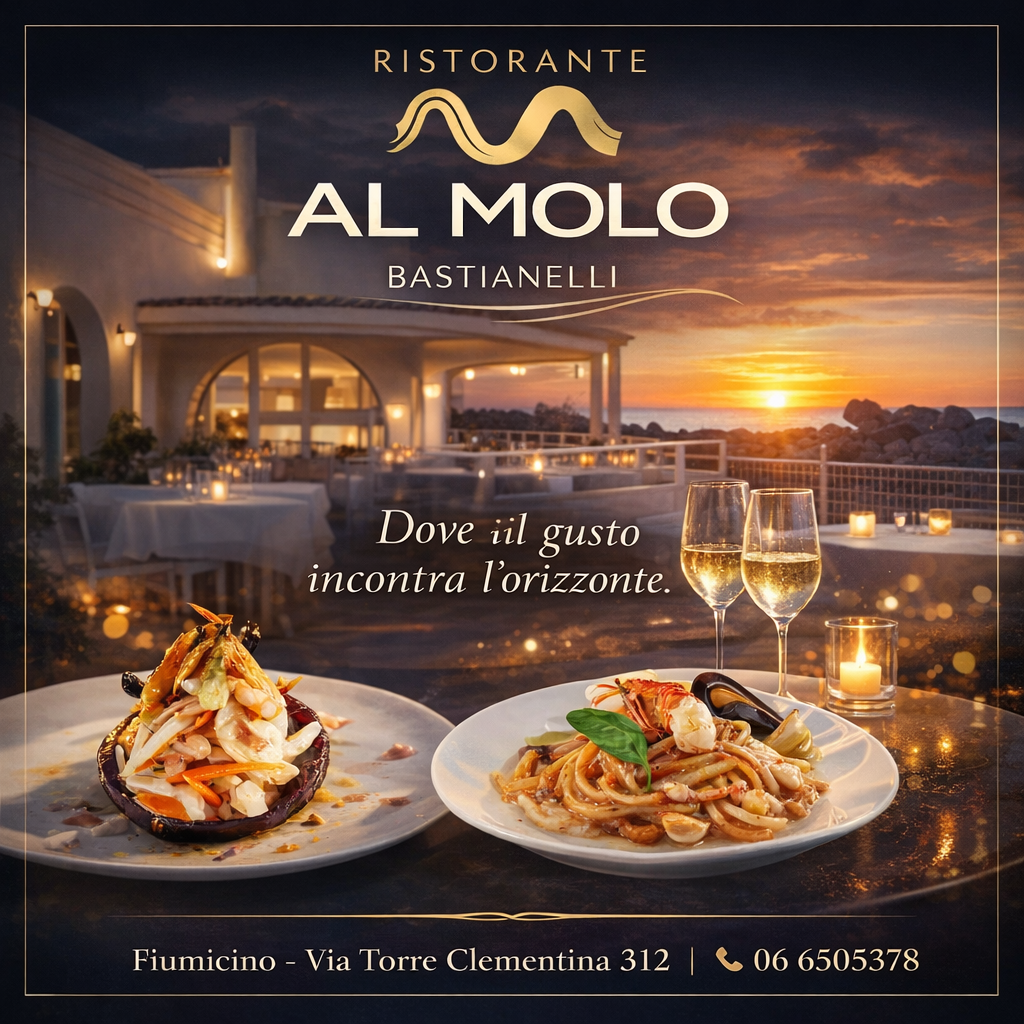Paolo Poletti: “Fermata in acque internazionali dalla Marina israeliana, la Global Sumud Flotilla rilancia il dibattito sulla legalità del blocco di Gaza e mette a nudo i limiti del nuovo piano di pace americano”

La Global Sumud Flotilla, composta da circa 40–50 imbarcazioni con a bordo quasi 500 attivisti e rappresentanti provenienti da oltre 40 Paesi, è stata abbordata in acque internazionali dalla Marina israeliana a circa 70 miglia da Gaza.
Tra i fermati figura anche Greta Thunberg, simbolo di un attivismo civile e transnazionale che negli anni ha saputo catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica.
Israele ha giustificato l’operazione come necessaria per far rispettare il blocco navale imposto su Gaza. Ma la legittimità di questo blocco resta profondamente controversa.

Da un lato, il Manuale di San Remo del 1994 consente, in linea di principio, l’intercettazione di navi in alto mare che intendano violare un blocco dichiarato e notificato.
Dall’altro, numerosi organismi delle Nazioni Unite, giuristi ed esperti indipendenti denunciano da anni il
blocco di Gaza come una forma di punizione collettiva, dunque contrario al diritto internazionale
umanitario.
Anche qualora si volesse ammettere la validità formale del blocco, le modalità operative con cui la Marina
israeliana ha condotto l’abbordaggio – uso della forza sproporzionata, impiego di sostanze irritanti e di
mezzi coercitivi non convenzionali – sollevano seri dubbi di liceità e rafforzano la percezione di un
comportamento che travalica i limiti del diritto.

Reazioni mediatiche: l’asimmetria della narrazione
Le reazioni della stampa occidentale mostrano un quadro differenziato:
⁃ Italia: la copertura si è concentrata soprattutto sulla sicurezza dei connazionali coinvolti e sulla gestione
dei fermi da parte del governo. Le narrazioni dominanti hanno privilegiato il linguaggio istituzionale
(“intercettazione”, “trasferimento ad Ashdod”), riducendo il dibattito sulla legalità dell’azione militare;
⁃ Europa: numerose testate – dal Guardian a Le Monde, passando per media scandinavi – hanno
sottolineato il punto giuridico centrale, ovvero la contestazione della legalità di un abbordaggio in acque
internazionali e la tensione con il diritto internazionale umanitario;
⁃ Stati Uniti: i principali media hanno mantenuto un tono più neutro e istituzionale, riportando la
posizione israeliana in termini di sicurezza e legittima difesa, senza però entrare a fondo sulle implicazioni
umanitarie e legali.
Il risultato è un’asimmetria della narrazione che tende, in parte, a normalizzare l’uso della forza da parte di Israele, mentre in Europa si aprono spazi critici più visibili.

Il valore politico e morale della Flotilla
La Flotilla non è solo una questione giuridica. Ha un forte valore simbolico e politico. Il nome Sumud, che
significa “fermezza” in arabo, richiama la tradizione della resistenza civile nonviolenta.
Il carattere internazionale dell’iniziativa, con la partecipazione di giuristi, parlamentari, attivisti e volontari
di diversi continenti, amplifica il suo significato: una presa di posizione collettiva della società civile
transnazionale contro l’assedio di Gaza e a favore dei diritti fondamentali dei civili palestinesi.
In questo senso, la Flotilla rappresenta un’azione che trascende i confini nazionali e che si colloca su un
piano di legittimità morale ben più ampio di quello giuridico, mettendo in discussione le basi stesse della
narrazione securitaria israeliana.

Il piano Trump: pace o controllo?
Sul piano politico, la premier Meloni ha sostenuto che l’iniziativa della Flotilla rischierebbe di compromettere il piano di pace in 20 punti presentato da Donald Trump il 29 settembre, sostenuto anche dalla mediazione del Qatar.
Quel piano prevede un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi, un ritiro graduale delle forze israeliane da Gaza e la creazione di una governance “tecnocratica” sotto supervisione internazionale. In prospettiva, promette una possibile autodeterminazione palestinese.
Tuttavia, i punti critici sono evidenti: l’esclusione problematica di Hamas da ogni ruolo di governo, la condizionalità ambigua sul ritiro israeliano, l’assenza di una chiara prospettiva statuale e la marginalizzazione delle questioni di Cisgiordania e colonie.
Più che un progetto di pace, il piano appare come una smilitarizzazione forzata e un controllo esterno di Gaza, che garantisce benefici immediati a Israele e offre ai palestinesi solo prospettive vaghe e condizionate.

Le contraddizioni interne in Israele
Un ulteriore elemento riguarda la politica interna israeliana. Se Netanyahu ha formalmente accolto il piano, i leader dell’ultra-destra – in primis Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir –
lo hanno già bocciato o condizionato: niente ruolo all’Autorità Palestinese a Gaza, nessuna concessione a uno Stato palestinese, mantenimento indefinito della presenza militare israeliana.
Netanyahu stesso, nel parlare al pubblico interno, ha escluso una piena sovranità palestinese.
Questo mostra che il piano è fragile ancor prima di essere valutato da Hamas o dalla comunità internazionale: le resistenze ideologiche interne rischiano di svuotarne i contenuti.
In questo contesto, sostenere che la Flotilla costituisca un pericolo per il piano appare del tutto inconsistente: il vero ostacolo non è l’azione nonviolenta della società civile internazionale, ma le contraddizioni della politica israeliana, dominata dall’ultra-destra.

La vicenda della Global Sumud Flotilla rivela la distanza tra la legalità proclamata e la legalità sostanziale del diritto internazionale.
Mentre Israele consolida un blocco contestato come illegittimo, la società civile transnazionale propone forme di resistenza nonviolenta che riaffermano diritti universali e denunciano l’uso della forza come strumento di controllo politico.
Resta chiaro che il comportamento del governo israeliano, spinto da una leadership condizionata dall’ultra-destra, non solo è illegale sul piano del diritto internazionale, ma risulta anche intollerabile sul piano etico e politico.

Un’ultima considerazione ispirata da Beppe Severgnini. Molti hanno definito l’azione della Flotilla “irragionevole”.
Può darsi che lo sia, se misurata con i criteri del calcolo politico e della convenienza immediata. Ma la storia insegna che senza gesti “irragionevoli” nessun grande cambiamento sarebbe stato possibile.
Era “irragionevole” Rosa Parks quando rifiutò di cedere il posto a un bianco su un autobus a Montgomery, dando avvio al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.
Era “irragionevole” Gandhi quando marciò per centinaia di chilometri per raccogliere simbolicamente un pugno di sale contro il monopolio britannico. Eppure quel gesto incrinò l’autorità coloniale.

Era “irragionevole” per molti il giovane sconosciuto che si mise di fronte ai carri armati in piazza Tienanmen: tuttavia quell’immagine è rimasta incisa nella coscienza universale come simbolo di libertà.
La Flotilla di Gaza si colloca in questa tradizione: un atto apparentemente sproporzionato, privo di chance immediate di successo, ma capace di parlare al mondo con la forza dei simboli.
E ricordarci che la storia spesso non la cambiano i compromessi prudenti, ma la fermezza irragionevole di chi osa sfidare l’ingiustizia.
Prof. Paolo Poletti